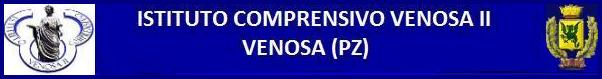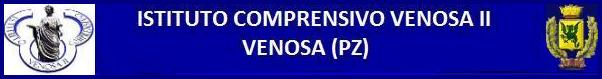|
 Venosa sorge
sul limite est della Basilicata, quasi al confine con la Puglia, in una grande vallata delimitata dal Vulture e dalle Murge. La ricerca della
struttura degradata del centro storico fra vicoli, case cadenti, cortili, loggiate impenetrabili, alla scoperta del patrimonio artistico, notevole ma
disarticolato , è difficile. Il pianoro sul quale sorge doveva presentarsi,
durante il Quaternario, come una estesa palude sulla quale nel tempo si è
impiantato un sistema idrografico che, ostacolato dalle manifestazioni
vulcaniche del Vulture, ha permesso la formazione di piccoli corsi fluviali,
laghi poco profondi e acquitrini, ambienti, cioè, favorevoli alla diffusione
di una ricca fauna, oggetto di caccia da parte dell’uomo preistorico. Molti
sono i reperti dell’età paleolitica rinvenuti nelle contrade di Loreto,
Terranera, Notarchirico, Sansanello etc.. Dopo un lungo periodo di
tempo, tracce archeologiche hanno mostrato l’esistenza di un insediamento
sannitico al quale fu, forse, imposto il nome di " Venotza ", di origine
ignota, donde Venossia, Venosia e Venusia?!! Se "Benoth " vuol dire qualcosa
come Venere, il fenicio " Benossa " indicherebbe un luogo di bellezza. Venosa sorge
sul limite est della Basilicata, quasi al confine con la Puglia, in una grande vallata delimitata dal Vulture e dalle Murge. La ricerca della
struttura degradata del centro storico fra vicoli, case cadenti, cortili, loggiate impenetrabili, alla scoperta del patrimonio artistico, notevole ma
disarticolato , è difficile. Il pianoro sul quale sorge doveva presentarsi,
durante il Quaternario, come una estesa palude sulla quale nel tempo si è
impiantato un sistema idrografico che, ostacolato dalle manifestazioni
vulcaniche del Vulture, ha permesso la formazione di piccoli corsi fluviali,
laghi poco profondi e acquitrini, ambienti, cioè, favorevoli alla diffusione
di una ricca fauna, oggetto di caccia da parte dell’uomo preistorico. Molti
sono i reperti dell’età paleolitica rinvenuti nelle contrade di Loreto,
Terranera, Notarchirico, Sansanello etc.. Dopo un lungo periodo di
tempo, tracce archeologiche hanno mostrato l’esistenza di un insediamento
sannitico al quale fu, forse, imposto il nome di " Venotza ", di origine
ignota, donde Venossia, Venosia e Venusia?!! Se "Benoth " vuol dire qualcosa
come Venere, il fenicio " Benossa " indicherebbe un luogo di bellezza.
Un’altra
tradizione vuole che Diomede, portato da una tempesta nel paese dei Dauni,
abbia fondato Venosa traendo il nome da Venere , per placare l’ira della dea
da lui ferita a Troia: Il Cimaglia riti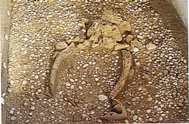 ene Venosa termine caldeo, tradotto
in latino con il significato di " Vexilium ferens "in quanto città a capo
dei paesi vicini. Altri autori fanno derivare la denominazione dalle
numerose vene d’acqua, dai vini pregiati, dalla fondatrice Venilia, moglie
di Dauno, il re soccorso da Diomede nella guerra contro i Messapi. E’ nel
321 a.C. che si hanno i primi rapporti con Roma, al tempo della II guerra
Sannitica, la città fu espugnata dopo un lungo e sanguinoso assedio.. ene Venosa termine caldeo, tradotto
in latino con il significato di " Vexilium ferens "in quanto città a capo
dei paesi vicini. Altri autori fanno derivare la denominazione dalle
numerose vene d’acqua, dai vini pregiati, dalla fondatrice Venilia, moglie
di Dauno, il re soccorso da Diomede nella guerra contro i Messapi. E’ nel
321 a.C. che si hanno i primi rapporti con Roma, al tempo della II guerra
Sannitica, la città fu espugnata dopo un lungo e sanguinoso assedio..
Negli anni in
cui si svolse la III guerra Sannitica fu perfezionata la conoscenza dei
luoghi, consolidata l’opera romana, apprezzata meglio l’importanza
strategica di Venosa, che nel 291 a.C. venne istituita colonia, prima di
diritto latino e poi di diritto romano. Roma ebbe grande cura e rispetto per
Venosa, non abolì le magistrature locali, le istituzioni senatorie e
l’esercito. Sotto l’Impero fu importante sede nell’arte della lana, e da
Costantino in poi la Chiesa Venosina
prese parte ai Concili Ecumenici Romani. Non si può non ricordare la
gigantesca figura di chi rappresenta simbolicamente la grandiosità del genio
venosino : Quinto Orazio Flacco. Dalla sua opera letteraria emerge con
saggezza la lettura delle caratteristiche dell’uomo del suo tempo, e per lui
Venosa nutre eterna riconoscenza.
Con gli
Ostrogoti fu capitale della Puglia e della Calabria e solo sotto i
Longobardi fu ridotta ad una fortezza dipendente dal Castaldato di Acerenza,
vale a dire di possesso diretto del re, anche se situata nel Ducato di
Benevento. Nel 622 l’imperatore d’Oriente, Costante II, la liberò dai
longobardi.
I saraceni
saccheggiarono poi la città nel IX secolo e se ne impadronirono per quindici
anni, fino a quando vennero sconfitti da Ludovico II. Nel 976 fu
assoggettata a Bisanzio,
 alle dipendenze del Catapano di Bari. Tornò a
fiorire con i normanni, i fratelli Guglielmo, Drogone e Umfredo, figli di
Tancredi d’Altavilla, poi sepolti nella SS. Trinità. Rispetto all’Alto
Medioevo, i secoli XI, XII e XIII rappresentano per Venosa una stagione di
grandi realizzazioni urbane. La conquista normanna coincise col
perfezionamento dell’organizzazione feudale. I feudatari locali impedirono
l’affermarsi dell’autonomia comunale , tuttavia la città crebbe e si dotò di
edifici che diventarono l’orgoglio cittadino. Si verificò l’abbandono sempre
più marcato dell’area nord - orientale del promontorio ( città romana ). La
crescita urbana continuò con gli Svevi, acquisendo le caratteristiche
tuttora conservatesi. La dominazione normanna è fondamentale per l’intera
vicenda artistica della Basilicata. Federico II dichiarò Venosa città
appartenente alla corona, ne derivarono privilegi sovrani che resteranno
vigenti fino alla dominazione angioina. Durante il periodo federiciano a
Venosa si respirava una certa vivacità intellettuale : Riccardo da Venosa
compose un poema in versi " De Paulino et Polla liber " , presentato
personalmente a Federico in occasione di una sua sosta nella città. Nel XIII
secolo viene istituito il fondaco del sale che , proveniente da Barletta,
veniva distribuito alle altre città lucane. Nel 1266, divenuto re di Napoli
Carlo d’Angiò
si concluse per Venosa un florido periodo e cominciò una lenta decadenza,
essendo legata alle varie dina alle dipendenze del Catapano di Bari. Tornò a
fiorire con i normanni, i fratelli Guglielmo, Drogone e Umfredo, figli di
Tancredi d’Altavilla, poi sepolti nella SS. Trinità. Rispetto all’Alto
Medioevo, i secoli XI, XII e XIII rappresentano per Venosa una stagione di
grandi realizzazioni urbane. La conquista normanna coincise col
perfezionamento dell’organizzazione feudale. I feudatari locali impedirono
l’affermarsi dell’autonomia comunale , tuttavia la città crebbe e si dotò di
edifici che diventarono l’orgoglio cittadino. Si verificò l’abbandono sempre
più marcato dell’area nord - orientale del promontorio ( città romana ). La
crescita urbana continuò con gli Svevi, acquisendo le caratteristiche
tuttora conservatesi. La dominazione normanna è fondamentale per l’intera
vicenda artistica della Basilicata. Federico II dichiarò Venosa città
appartenente alla corona, ne derivarono privilegi sovrani che resteranno
vigenti fino alla dominazione angioina. Durante il periodo federiciano a
Venosa si respirava una certa vivacità intellettuale : Riccardo da Venosa
compose un poema in versi " De Paulino et Polla liber " , presentato
personalmente a Federico in occasione di una sua sosta nella città. Nel XIII
secolo viene istituito il fondaco del sale che , proveniente da Barletta,
veniva distribuito alle altre città lucane. Nel 1266, divenuto re di Napoli
Carlo d’Angiò
si concluse per Venosa un florido periodo e cominciò una lenta decadenza,
essendo legata alle varie dina stie che si succederanno sul trono. Un certo
sviluppo culturale, oltre che urbanistico, si ebbe quando , negli ultimi
decenni del XV secolo Venosa legò il suo destino a Pirro del Balzo,
dispotico feudatario che esercitava il suo potere tra l’autorità dei re aragonesi e l’egemonia locale dei baroni. Egli realizzò un assetto
urbanistico destinato a migliorare le condizioni di vita di tutta la
popolazione. stie che si succederanno sul trono. Un certo
sviluppo culturale, oltre che urbanistico, si ebbe quando , negli ultimi
decenni del XV secolo Venosa legò il suo destino a Pirro del Balzo,
dispotico feudatario che esercitava il suo potere tra l’autorità dei re aragonesi e l’egemonia locale dei baroni. Egli realizzò un assetto
urbanistico destinato a migliorare le condizioni di vita di tutta la
popolazione.
Apportò un
contributo determinante alla formazione del volto monumentale della città,
volendo affermare il proprio prestigio sulla comunità attraverso
l’architettura. Venosa raggiunse una nuova dimensione grazie ad una
ridefinizione del perimetro murario, che escluse definitivamente la città
romana. Si determinò un polo urbano in cui si imponevano tre monumenti : il
Castello, la SS. Trinità e la Cattedrale di S. Andrea. Dopo la morte di
Pirro e la sconfitta degli Aragonesi la città passò al gran capitano
Fernando Consalvo di Cordova che rimase signore di Venosa fino all’acquisto
del feudo da parte dei Gesualdo. Da allora Venosa cominciò ad avere un suo
stemma con un basilisco in campo d’oro, con una zampa levata ed appoggiata
alla gola, e con coda serpentina: stemma che venne aggiunto alla vecchia m edaglia
con la scritta " Respublica Venusina", con un’immagine di dea: Nel 1503 una
devastante pestilenza determina un forte decremento demografico. Molte
chiese vennero costruite allora come ringraziamento per la fine del
flagello. I Gesualdo, protagonisti ora della vita politica e culturale,
furono sensibili al fascino della vita mondana e resero Venosa attivo centro
intellettuale negli anni di trapasso dal Rinascimento alla Controriforma. In
questa ripresa culturale emergono personalità di spicco, come Pomponio,
Lucio e Bartolomeo Maranta, Luigi Tansillo e A. T. Cappellano. Dopo i
Gesualdo il feudo passa ai Ludovisio, il passaggio segna l’inizio di una
stagione di crisi urbana, che si protrarrà sino alla Rivoluzione Francese,
tuttavia la produzione di testi letterari, e di documenti iconografici
sarà rilavante. Alla fine del Settecento la città fu nelle mani della
famiglia Caracciolo di Torella, nonostante piccoli segnali di vitalità,
l’economia cittadina era fuori dai grandi circuiti produttivi e commerciali
del Regno di Napoli. Le condizioni sociali di estrema miseria, il degrado
delle strutture fisiche e l’isolamento economico, alla fine del XVIII secolo
, destavano preoccupazione. edaglia
con la scritta " Respublica Venusina", con un’immagine di dea: Nel 1503 una
devastante pestilenza determina un forte decremento demografico. Molte
chiese vennero costruite allora come ringraziamento per la fine del
flagello. I Gesualdo, protagonisti ora della vita politica e culturale,
furono sensibili al fascino della vita mondana e resero Venosa attivo centro
intellettuale negli anni di trapasso dal Rinascimento alla Controriforma. In
questa ripresa culturale emergono personalità di spicco, come Pomponio,
Lucio e Bartolomeo Maranta, Luigi Tansillo e A. T. Cappellano. Dopo i
Gesualdo il feudo passa ai Ludovisio, il passaggio segna l’inizio di una
stagione di crisi urbana, che si protrarrà sino alla Rivoluzione Francese,
tuttavia la produzione di testi letterari, e di documenti iconografici
sarà rilavante. Alla fine del Settecento la città fu nelle mani della
famiglia Caracciolo di Torella, nonostante piccoli segnali di vitalità,
l’economia cittadina era fuori dai grandi circuiti produttivi e commerciali
del Regno di Napoli. Le condizioni sociali di estrema miseria, il degrado
delle strutture fisiche e l’isolamento economico, alla fine del XVIII secolo
, destavano preoccupazione.
E’’ in questo
contesto storico che alcuni venosini, tra cui i Rapolla, promossero la
costituzione di una municipalità repubblicana, perdendone poi il controllo a
causa di rivolte popolari. Nel 1808 è la terza città della Basilicata, dopo
Melfi e Matera, per il numero dei possedimenti, ad avere diritto attivo e
passivo nel Parlamento Nazionale Napoleonico.
Non manca il
coinvolgimento attivo nelle sommosse risorgimentali, nel 1848 uno studente
venosino, L. La Vista, rimane ucciso a Napoli, sotto gli occhi del padre,
durante i moti rivoluzionari.
Un’immagine
romantica della città di Venosa ci viene offerta , verso la metà
dell’Ottocento, da Edward Lear, un viaggiatore inglese ; la sua descrizione,
corredata da una serie di disegni di pregevole fattura, offre interessanti
spunti di considerazione. "…..l’antica città di Venosa, pittoresca quant’altre
mai, sorge sull’orlo di un ampio e profondo vallone, con il Castello e la
Cattedrale che guardano dall’alto l’intera area urbana… Non ho mai visto
paesaggio più suggestivo in questa parte del Regno."
Dalla fine
dell’Ottocento non si registrano eventi di nota, ciò che resta è la memoria
di un passato illustre, che continua a sollecitare ricerche e studi. |